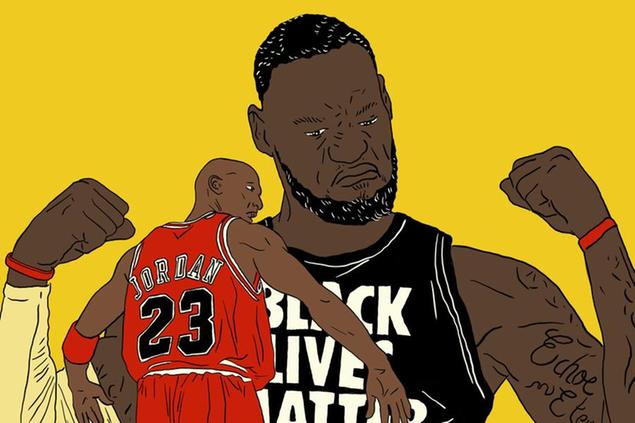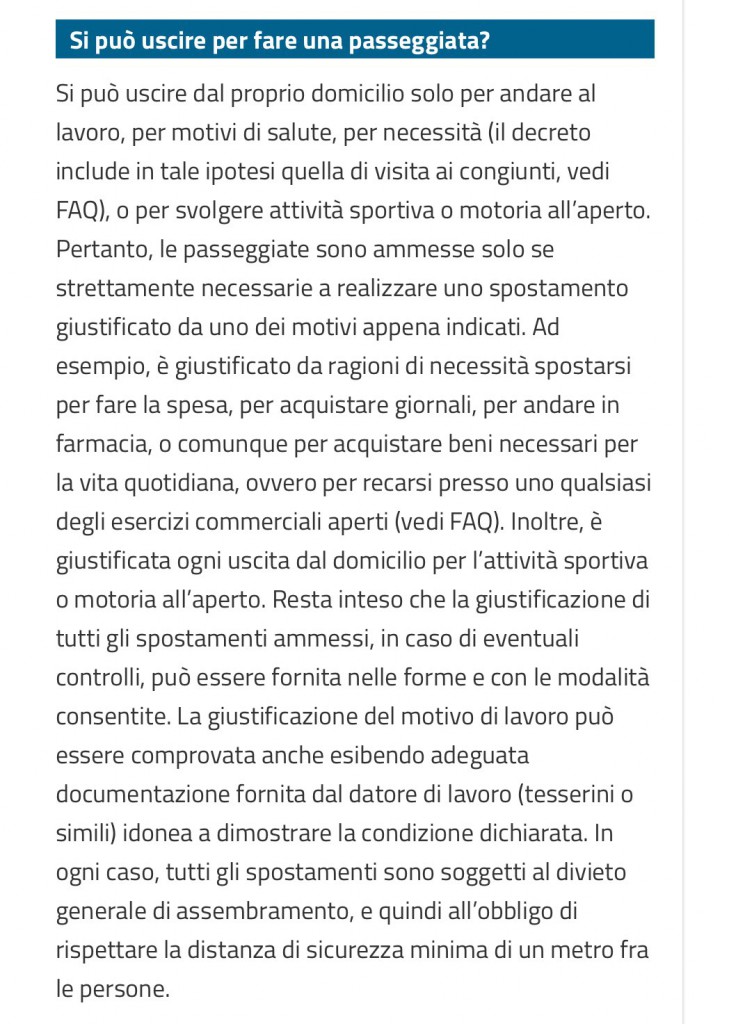La disastrosa gestione italiana della pandemia di Coronavirus: numeri inattendibili, mancanza di trasparenza e il fallimento definitivo di una classe politica improvvisata.
La scorsa notte sono uscito sul terrazzo per prendere una boccata d’aria fresca prima di andare a dormire. Roma, di notte, emette un rumore bianco inesausto, da grande organismo che non dorme mai del tutto. Non è niente di sommesso, né di particolarmente crepuscolare, è una specie di rombo, basso, ondulato, persino greve, a tratti. Carlo Levi ha scritto che a Roma di notte “par di sentir ruggire i leoni”. Qualcosa del genere, in effetti.
Ha anche aggiunto “nato da macchine è un suono animalesco, che par venire da viscere nascoste o da gole aperte invano a cercare una parola impossibile (…) è un rumore pieno d’ozio, come uno sbadiglio belluino, indeterminato e terribile”. Di certo c’è che si tratta del risultato più o meno costante di un’addizione mutevole: è il rumore degli affari umani – seppur in chiave minore, notturna appunto.
L’altra notte mi è parso subito chiaro, con l’autoevidenza di un’intuizione istintiva, che la situazione era cambiata. Non c’era silenzio, quello no. Il silenzio autentico, profondo, a Roma è un fenomeno che si presenterà – forse – alla fine dei tempi. Mancava però il respiro collettivo della città e ogni singolo suono era riconoscibile in una sua inedita specificità. Sotto una cupola di nuvole basse e opalescenti sono rimasto ad ascoltare.
Ho udito distintamente il gorgheggiare di due diversi gabbiani, il rumore di un tram che sferragliava di fronte a un ministero nemmeno troppo vicino, il fischio di una macchina per le pulizie dei pavimenti nell’ospedale davanti a casa, un singolo passante che prendeva a calci una bottiglia. Ogni suono separato dall’altro, con delle pause, queste sì, fatte di qualcosa che assomigliava a un autentico silenzio.
Erano assenti i leoni, il rumore bianco indistinguibile, la somma sonora della vita nella città. Non c’era cioè traccia di quella sorta di dichiarazione d’indifferenza e superiorità che la capitale dedica a qualsiasi suo abitante, come un’eterna scrollata di spalle. Era una notte della pandemia, la sua povertà di suoni era il verso della quarantena, la controparte notturna delle molto celebrate canzoni alle finestre.
Quel silenzio era il suono del vuoto, parziale eppure notevole, in cui è costretto il mio Paese in questi giorni. È arrivato come un esito inaspettato, dopo settimane di discorsi contraddittori, di suicide fughe di notizie, di provvedimenti abbozzati, di leader improvvisati che si dimostrano esattamente quello che sono – dei principianti inadeguati –, di medici e infermieri lasciati senza mascherine e protezioni, di tamponi fatti con una metodologia che con ogni probabilità sottostima di diversi ordini di grandezza la reale dimensione della pandemia e di un rito – quello della conferenza stampa della protezione civile– che ogni giorno assume toni più surreali, dato che si recitano numeri che non hanno più alcuna capacità di descrivere la situazione reale del Paese.
Che ogni giorno qualcuno dica che l’Italia è il Paese che ha fatto più tamponi non conta assolutamente nulla, il parametro importante è quanti se ne fanno rispetto all’ampiezza della propria epidemia. Un rito questo della conferenza stampa che prima finirà, o prima sarà sintonizzato sui veri numeri, e meglio sarà per tutti, anche a costo che qualcuno ammetta di aver sbagliato.
Invece questi numeri parziali si continua a darli, si continua a ignorare che i tamponi sono fatti in larga maggioranza solo a ex contagiati e nuovi contagiati altamente sintomatici. Nulla o quasi per gli asintomatici o per i sintomatici normali, lasciati alle tachipirine e alla grazia di Dio nelle loro case, dove molti di loro si aggravano e muoiono soffocati nel giro di poche ore, soli come cani o al cospetto di famigliari impotenti, senza nessuno che li aiuti, senza che nessuno li porti in ospedale visto che in certe zone d’Italia oggi per un’ambulanza possono servire otto ore.
Scene terrificanti, indegne di un Paese democratico, drammi che finiscono per falsare anche il numero ufficiale dei morti visto che nessuno fa i tamponi ai cadaveri. Molti sindaci dei paesi del bergamasco hanno denunciato un’impennata di morti ben oltre la normale media statistica di questo periodo dell’anno, decessi che solo in piccola parte vengono attribuiti al Covid19.
In quei numeri nascosti – la somma di morti ufficiali e non ufficiali – possiamo provare a cercare la vera dimensione della mattanza, e, incrociandola poi con i dati internazionali sulla mortalità del virus, incominciare a capire le vere dimensioni dell’epidemia italiana. Facendolo intravediamo un disastro, un tracollo assoluto, nascosto da una mancanza di trasparenza iniziata forse per assurde ragioni d’immagine (non apparire un paese-lazzaretto per tutelare l’industria turistica) e poi aggravatasi per impreparazione, tracotanza e sottovalutazione.
Cosa pensano in queste ore i parenti delle vittime sentendo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlare dell’epidemia come di un momento utile per riflettere su sé stessi? Sono parole che sarebbero forse adatte alla penna di uno scrittore o di un filosofo, ma pronunciate da chi ricopre il ruolo di primo responsabile della gestione dell’emergenza, assomigliano di più a uno sfregio fatto a quanto abbiamo di più caro e non sono altro che l’ennesima dimostrazione di inadeguatezza.
È una questione di ruoli, ma è anche vero che se ancora esistesse un rispetto dei ruoli e della preparazione necessaria per svolgerli, Giuseppe Conte, privo com’è di una storia politica e di governo, difficilmente potrebbe essere Presidente del Consiglio italiano. Il dramma è infatti anche quello di essersi trovati di fronte a una crisi senza precedenti con una classe politica anch’essa senza precedenti, ma in negativo. E se in tempi normali sotto un comando inadeguato si vivacchia, ci si avvita in una decadenza inesorabile ma graduale – qualcosa che si può cioè sforzare d’ignorare – la tempesta perfetta mette a rischio la vita dell’intero equipaggio. Il naufragio è una possibilità immediata, chiaramente percepibile da tutti.
Chi si ripete che in fondo molti altri Paesi non stanno facendo poi meglio di noi dovrebbe capire che ragionamenti del genere sono la via più sicura per il collasso definitivo, per la tragedia ultima. Sono gli esempi positivi quelli da seguire, non quelli negativi. L’Italia prova coraggiosamente a reagire alle deficienze della sua leadership, lo fa attraverso l’azione di regioni e sindaci, con l’attivismo dei giornali e con una classe medica che parla pubblicamente e ogni giorno accetta un po’ di meno di essere celebrata retoricamente da un potere che non ha esitato a mandarla al massacro, impreparata e senza protezioni.
Nelle ore in cui Conte saltava da un programma all’altro a dire che il Paese era preparatissimo, i medici in tutta Italia venivano mandati al lavoro senza mascherine. Poi, non disponendo di protezioni in una quantità congrua, non essendosi organizzati per tempo, si è a lungo negata la loro utilità, in sfregio ad ogni logica. Abbiamo avuto conferenze tenute in ritardo mostruoso e senza la presenza della stampa, decreti raffazzonati, annunci contrastanti, fughe di notizie, autocertificazioni cartacee (come fosse il 1800) e cambiate infinite volte.
Abbiamo avuto la retorica degli angeli e l’inno nazionale sparato dalle casse e la bufala del “modello Italia” al posto degli stock di mascherine, delle tute anticontaminazione, degli antivirali anche per i sintomatici a casa, dei tamponi per i potenziali contagiati, anche se asintomatici. Delle app per il tracciamento delle persone in quarantena nessuna traccia. Cose degne di quei regimi che ora sgomitano per comprarsi la benevolenza degli italiani con l’invio di qualche aiuto, fra cui medici che avranno accesso alle nostre informazioni sensibili.
Fra queste nazioni – con estremo sfregio del ridicolo – siede anche la Cina. Un Paese che prima ha lasciato aperti, all’interno di città sovrappopolate, mercati privi di qualsiasi standard sanitario e a rischio spillover, e poi, a infezione iniziata, ha taciuto a lungo, permettendo così alla pandemia di diffondersi in tutto il pianeta. Un’imprudenza che costerà al mondo intero decine di migliaia di morti – nella migliore delle ipotesi – e un numero al momento incalcolabile di miliardi di euro in danni economici. Grazie comunque per le mascherine.
Tutto questo, tutto assieme, è davvero difficile da sopportare, e se è vero che ognuno di noi all’inizio di questa vicenda ha tentennato, si è augurato che la situazione non fosse poi così terribile come si diceva, è vero anche che le responsabilità degli esperti e di chi ha il comando in una democrazia avanzata, di chi cioè ha il dovere di tutelare la popolazione, sono ben diverse.
Da questo punto di vista lo stile di leadership apparentemente conciliante, moderata e prudente di Conte apparirà forse a qualcuno come rassicurante – agli italiani piace da sempre un decisore che non decide – ma all’atto pratico si risolve in inazione o azione ritardata, insufficiente. Il dramma dell’Italia in queste ore è anche il dramma di un Paese che negli ultimi anni si è incaponito nell’idea che al governo vadano benissimo gli incompetenti, gli improvvisati, gli estemporanei, li ha anzi agognati come soluzione – semplice e lineare – ad ogni problema.
È il dramma di un Paese che ha visto degenerare il dibattito televisivo nelle forme sempre meno informative dei talk show urlanti e superficiali e che oggi non riconosce le autentiche autorità nei differenti campi del sapere. È il dramma di un Paese che emargina con determinazione e progettualità le sue teste pensanti e che quando poi si trova alle prese con un cigno nero annaspa, orfano delle sue risorse migliori, e pensa piuttosto a tutelare la propria immagine, il consenso politico del momento, invece che la propria popolazione e il proprio futuro. Finito tutto questo bisognerà fare i conti, bisognerà partire da tutti questi errori, dall’accertamento delle responsabilità per costruire un’Italia profondamente diversa.
Nel silenzio di una Roma quasi spenta, ho immaginato suoni che tornavano uno dopo l’altro a formare il ruggito dei leoni, solo che questa volta erano suoni più intonati, disposti in un ordine migliore, più sensato, un ordine che permettesse di pensare al presente e al futuro con serenità. Una delle tragiche verità della storia è che disastri come guerre, o appunto epidemie, rimescolano le carte, fanno ripartire le società dopo averle quasi distrutte e essersi lasciati alle spalle morti e disperazioni indicibili.
Il problema con le opportunità che i grandi shock possono “offrire” non è soltanto morale – molti devono effettivamente morire – ma anche che è necessario lo shock adatto, in fondo una pandemia come quella del Coronavirus può colpire in maniera durissima le popolazioni per via del collasso dei sistemi sanitari ma rappresenta una minaccia ridotta per chiunque possa permettersi un piccolo reparto di terapia intensiva privato in casa, ovvero l’intera oligarchia del pianeta. Anche i meccanismi livellatori che hanno attraversato la storia dell’uomo con drammatica efficacia trasversale, oggi sono messi in discussione dalla tecnologia, per cui ogni teoria sull’apertura di nuovi spazi dopo tragedie collettive va riconsiderata alla luce di questi sviluppi. Fortunatamente però non c’è bisogno di augurarsi come unica condizione per la rinascita che la tragedia in corso diventi ancora più profonda e radicale. Si spera anzi il contrario.
Credo esista un’altra possibilità – ben più allettante rispetto alla distruzione creativa – e sia quella che a farci andare avanti, ad aiutare l’Italia a ripensarsi, potrebbe essere proprio lo spirito di unità e di cooperazione emerso nella nostra società durante le ore e i giorni di questo dramma collettivo. Potrebbe essere questo senso di comunità il lascito prezioso – e altrimenti irraggiungibile – dei sacrifici che per una volta stiamo facendo tutti quanti assieme, come italiani. Mi pare questa la vera promessa del silenzio disteso sopra Roma.
( Questo articolo è stato pubblicato venerdì 27 Marzo su Il Foglio – Foto LaPresse)